V° Consiglio Plenario
LA NOSTRA PRESENZA PROFETICA NEL MONDO
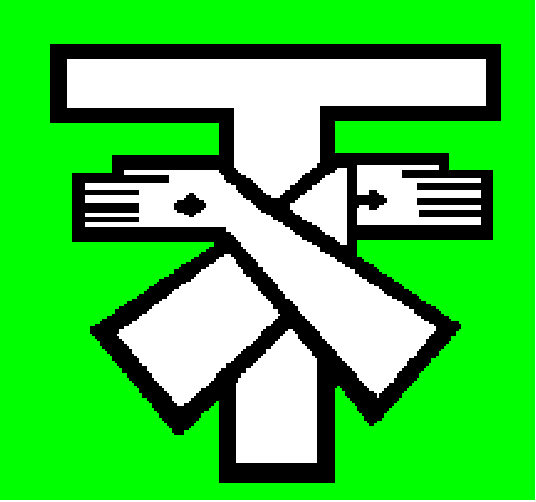 Garibaldi (Brasile), 31 agosto - 27 settembre 1986
Garibaldi (Brasile), 31 agosto - 27 settembre 1986
Note
Nota 1 Cf. Lett. circolare dell'1.11.1982 in Anal. O.F.M.CAP,. 98 (1982) 329-33.
Nota 2 Sulla spiegazione del senso, scopo, tema e titolo del V CPO cf. le riflessioni di p. Pedroso, ibid. 100 (1984) 283-287; 101(1985) 394-407 (testo bilingue, ital.-inglese).
Nota 3 Sui lavori della commissione preparatoria cf. ibid. 100 (1984) 243-246; convocazione: ibid., 101 (1985) 22-26, la «Proposta di lavoro»: 55-63, riunione dei delegati a Roma (7.15.1.1986) per preparare il «documento di lavoro»: ibid. 102-103 (1986-1987) 31-34. In sintesi vedi il volume: Sfide e controsfide. I Cappuccini italiani per il V CPO, a cura di C. Cargnoni, Roma 1986 12-16: questo volume raccoglie sistematicamente e per temi le risposte dei cappuccini italiani alla «Proposta di lavoro della commissione preparatoria» (2.2.1985). È utile leggere anche il «quaderno di studio» curato dal segretario della CISPCap. Francesco Gioia (ora vescovo di Camerino), Linee di lettura sull'inchiesta del V CPO (Agosto 1985) Roma 1985.
Nota 4 Si vedano al riguardo le acute osservazioni di Fulgenzio Francini in Sfide e controsfide, 13-16, 21, 40-42, 63-67, 81-85, 324-330.
Nota 5 La cronaca completa el V CPO radunato a Garibaldi (RS), Brasile (31 agosto - 27 sett. 1987) e stata redatta da Luciano Pastorello. Cf. Anal. O.F.M. Cap. 102-103 (1986-1987) 58-88.
Nota 6 Cf. Jean Lafrance, La preghiera del cuore, Civitella San Paolo (Roma), s.n.t.
Nota 7 Sull'inadeguatezza del linguaggio mistico cf. Massimo Naldini, 11 linguaggio dei mistici, Brescia 1986.
Nota 8 Cf. Carlo M. Martini, arciv. di Milano, La dimensione contemplativa della vita. Lettera al clero e ai fedeli (8.9.1980); S. Congr. per i Religiosi e gli Istituti Secolari, Vita religiosa. La sua dimensione contemplativa (12.8.1980), C. Cargnoni, Dimensione contemplativa della nostra vita francescana, in Boll. Uff. per i Frati Min. Cap. Prov. Serafica, Anno L, n. 1 (Numero speciale 1984), 101-120.
Nota 9 Tenendo presente questa precisazione, per non pensare che si tratti di un doppione tematico, rimandiamo alle note del II CPO, come pure a quelle del IV CPO relative all'argomento della «fraternità orante» (nn. 37-40); Per il cap. III delle costituzioni sulla preghiera si veda lo studio di O. Schmucki, La nostra vita di preghiera. Note sul capitolo III delle Costituzioni dei Frati Minori Cappuccini, in Italia Franc. 56 (1981) 109135.
Nota 10 Sul problema della comunicazione e i rischi dell'incomunicabilità moderna parla con suggestive riflessioni il card. Carlo M. Martini, arciv. di Milano, nella sua lettera pastorale «Effata, apriti» (11.8.1990). Cf. id., Comunicare nella Chiesa e nella società. Lettere, discorsi e interventi 1990, Bologna 1991; vedi anche più avanti, nn. 58, 70-71.
Nota 11 Si può qui rileggere utilmente la Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica su alcuni aspetti della meditazione cristiana, della Congregazione della Dottrina della Fede (15.10.1989).
Nota 12 Oltre la nota 86 del IV CPO, Si veda il fascicolo a cura dell'Ufficio di Ricerca e Riflessione dell'Ordine: Fraternità di ritiro e contemplazione nell'Ordine. Roma - Curia Generale Cappuccini 1990; Ronald; La vita contemplativa nel recente Magistero della Chiesa, Roma 1973; Jose Carlos Pedroso, Contemplazione in Italia Franc. 62 (1987) 327-338.
Nota 13 Cf. Cornelio Fabro, La preghiera nel pensiero moderno, Roma 1979; L'antropologia dei maestri spirituali. Atti del simposio organizzato dall'lst. di Spiritualità dell'Università Gregoriana (Roma 28 apr. - 1 maggio 1989), a cura di Ch. A. Bernard, Cinisello Balsamo 1991.
Nota 14 Cf. La preghiera cristiana, a cura di Ermanno Ancilli, Roma 1975; e ora La preghiera. Bibbia, teologia, esperienze storiche, 2 voll., a cura di E. Ancilli, Roma 1988 (note bibliog. nel vol. 11, 419-446); T. Goffi, L'esperienza spirituale oggi. Le linee essenziali della spiritualità cristiana contemporanea, Brescia 1984; Ch. A. Bernard, Contemplazione, in Nuovo Dizionario di spiritualità, a cura di Stefano De Fiores e Tullio Goffi, Roma, EP 1979, 262-278; Preghiera, in Diz. Ist. di Perf. Vll, Roma 1983, 580-719; Priere, in Dict. Spirit. Xll, Paris 1986, 2196-2347.
Nota 15 Cf Cost. 45, 5, 11 CPO, n. 7-8, 18; Nino Barraco, Francesco, uomo di pace e fratello universale, in Francesco d 'Assisi, novità di Chiesa, Palermo 198, 119-125; Vergilio Gamboso, Francesco, fratello di tutti, in Presbyteri 15 (1982) 429-438; vedi anche più avanti, nota 114.
Nota 16 Cf. Cost. 45, 1.
Nota 17 Cf. I CPO, n. 17; 111 CPO, nn. 8-9, 21-22, 24, 30. - P. Mariotti, Contestazione profetica, in Nuovo dizionario di spiritualità cit., 278-288.
Nota 18 Cf. Cost. 1, 6; 13, 4; 48, 5; 148, 1-4. - B. Calati, Parola di Dio, ibid., 1134-1151.
Nota 19 Cf. A. Barruffo, Discernimento, in Nuovo dizionario di spiritualità, 419-430.
Nota 20 Cf. Riccardo Barile, Discernimento per evangelizzare, in Settimana, n. 26 (7 luglio 1991) 13.
Nota 21 La bibliografia sull'argomento e assai vasta. Proponiamo solo alcuni titoli significativi: Carmine De Filippis, Profezia e contemplazione in san Francesco d'Assisi, in Italia Franc. 61 (1986) 27-40; L. Lehmann, Preghiera e pratica della meditazione in Francesco d'Assisi, in Italia Franc. 65 (1990) 333-347, F. Refatto, Uomo fatto preghiera. Francesco d 'Assisi maestro di preghiera. Sussidi e schede, Padova 1990.
Nota 22 Il passo è dedotto dal Testamento di san Francesco. Cf. Documento di lavoro, Roma 1986, 20-23 (= Allegato II); L. Canonici, Lebbroso lebbrosari, in Dizionario francescano. Spiritualità, Padova 1983, 837-854; R. Manselli, San Francesco dal dolore degli uomini a Cristo crocifisso. in Anal. T.O.R. 16 (1983) 191-210, e sul significato del rapporto di Francesco coi lebbrosi cf. gli articoli di A. Umberto Valtorta, L'uomo creato ad immagine del Figlio «secondo il corpo» negli scritti di Francesco d 'Assisi. (Approccio per un'antropologia cristica), in L'uomo e il mondo alla luce di Cristo. Atti del secondo simposio tenuto a Rieti 61-21 aprile 1985), a cura di V. Battaglia, Vicenza 1986, 151-226; Czeslaw Gniecki, Visione dell'uomo negli scritti di Francesco d'Assisi, Roma 1987.
Nota 23 Ezio Franceschini, Cristo amato nella esperienza di san Francesco, in id., Nel segno di Francesco, a cura di F. Casolini e G Giamba, S. Maria degli Angeli - Assisi, 1988, 320-336; G lammarone, Gesù Cristo nella spiritualità di san Francesco, in Misc. Franc. 91(1991) 23-88.
Nota 24 Cf. Cost 46, 6. - Eric Doyle, Francesco e il Cantico delle creature. Inno della fratellanza universale, Assisi 1982, Temi di vita francescana, Roma 1987, 89-114.
Nota 25 Cf. Cost. 25, 5; 30, 3; 46, 6; 11 CPO, n. 17-18; IV CPO, nn. 40 e 53. - vedi ora questi piccoli trattati di preghiera raccolti insieme in I Frati Cappuccini. Documenti e testimonianze del primo secolo, a cura di C. Cargnoni, vol. III/1, Perugia 1991, 235-1729, con il lungo studio introduttivo che analizza questa letteratura spirituale (ibid., 25-234).
Nota 26 Cf. Cost. 53, 1; 11 CPO, n. 20; IV CPO, n. 40; utile anche il discorso del ministro generale Flavio R. Carraro ai frati di Genova (12,3. 1986) sulla preghiera: Acta ufficiale per i frati min. cap. Prov. Genova, fasc. 75 (genn. '85 - giugno '86), 18-26. - O. Schmucki, Preghiera e vita contemplativa nella legislazione e vita dei primi frati minori cappuccini, Roma 1989, C. Cargnoni, I primi Iineamenti di una «scuola cappuccina di devozione», in Italia Franc. 59 (1984)111-140; vedi inoltre le note 31 del 11 CPO, 79 e 95 del IV CPO.
Nota 27 Cf. Cost. 52, 1; 53, 6; 11 CPO, n. 10; IV CPO, nn. 36a-37. - Optatus van Asseldonk, La sfida cappuccina nella Chiesa e nel mondo. La libertà evangelica oggi, in Laurent. 26 (1985) 465- 496, specie 490-496.
Nota 28 Cf. 111 CPO, n. 27; IV CPO, nn. 33, 38, 40.
Nota 29 Cf. 11 CPO, n. 2.
Nota 30 Cf. Cost. 46, 4;11 CPO, nn. 14, 16; IV CPO, n. 40. - Sull'attenzione alle varie culture cf. IV CPO, nn. 23-33; e la lett. circolare del ministro generale del 13.6.1986.
Nota 31 Per la formazione permanente cf. Cost. 43, 3; IV CPO, nn. 22 e 74-75; sulla necessità di formare i formatori cf. IV CPO, nn 39., 42, 73 e 81. - Aurelio Laita, Rapporto fra formazione permanente e consiglio plenario dell'Ordine. Il V CPO in prospettiva di formazione permanente, in Italia Franc. 61(1986)157- 172.
Nota 32 Cf. Cost. 52-53; e più avanti, al n. 23 a.
Nota 33 Cost. 57, 1-2; 88, 3-8; 90, 1;11 CPO, n. 28; IV CPO, nn. 44 e 74.
Nota 34 Cost. 59, 5; 60, 4; 11 CPO, n. 10; IV CPO, nn. 37, 39; e sopra, le note 25-27. - Per alcune forme tradizionali rinnovate cf. Ignacio Larranaga, Mostrami il tuo volto. Verso l'intimità con Dio, Roma 1984.
Nota 35 Cost. 56, 1-3;1 CPO, n. 2 e 39;11 CPO, n. 25; IV CPO, n. 37; e più avanti, n. 56f.
Nota 36 Cost. 89, 1-4;1 CPO, n. 34; IV CPO, n. 38.
Nota 37 Cost. 146, 5; 178, 4; 111 CPO, n. 41. - Giocondo Pagliara, Il centro d'ascolto nella missione popolare, in Italia Franc. 63 (1988) 275-284.
Nota 38 Si veda, come esempio, la bella lettera dell'ex-ministro generale Pasquale Rywalski in cui comunica i frutti di un incontro e scambio di esperienze di preghiera svolto a Bigorio nel 1981. Cf. P. Rywalski, Lettere ai suoi frati 1970-1982), a cura di C. Belli, Roma 1982, 398-405.
Nota 39 Cf. Cost. 83-84.
Nota 40 Cf. Cost. 5, 4-5;111 CPO, nn. 17 e 40; IV CPO, nn. 10 e 23.
Nota 41 Cf. I CPO, n. 20.
Nota 42 Contro l'individualismo sono già intervenuti variamente i superiori dell'Ordine e i precedenti Consigli Plenari: I CPO, n. 45, 50;11 CPO, n. 35; IV CPO, nn. 19, 33, ecc.
Nota 43 Vedi le calde riflessioni di Michael H. Crosby, Profetismo emergente nel nostro Ordine, in Italia Franc. 62 (1987) 283-304, e a parte, in Vita e attività apostolica dei cappuccini. Proposte e contributi al V CPO, Roma 1986, 75- 96.
Nota 44 Cf. Cost. 83-100;1 CPO, nn. 30-45; IV CPO, nn. 13-22.
Nota 45 Cf. Optatus van Asseldonk, Vita nostra evangelica in fraternitate, in La lettera e lo spirito II, Roma 1985, 539-550, vedi anche la relazione del Min. generale Flavio R. Carraro a Camerino ai novizi: di cammino e le attese dell'Ordine in questi ultimi anni, in Anal. O.F.M. Cap. 105 (1989) 186-195; come pure la conferenza dettata ai frati genovesi l'11.3.1986 sulla fraternità, in Acta Ufficiale per i frati min. cap. Prov. Genova, tasc. 75 (genn. '85 - giugno '86)11-17.
Nota 46 Cf. Cost. 48, 1-5; 50-51; I CPO, n. 21; 11 CPO, nn. 36-39.
Nota 47 IV CPO, n. 80; vedi anche le riflessioni dei cappuccini italiani, in Sfide e controsfide cit., 203-225.
Nota 48 Questo aspetto e sottolineato anche dal I CPO, n. 21f, 49, IV CPO, n. 42.
Nota 49 Cf. Cost. 84, 2; 142, 3; 158, 2; sulla revisione di vita: 11 CPO, n. 33; III CPO, n. 33; IV CPO, n. 35 e 80; sul dialogo: I CPO, nn. 43 e 51; IV CPO, nn. 74 e 83; inoltre vedi le note 51 53
Nota 50 Cf. Cost. 105, 2; 160, 1-4. - L'importanza della correzione fraterna per superare ogni spirito di divisione e mantenere il fervore religioso e stato uno dei criteri maggiormente sottolineati nei primordi del francescanesimo e della riforma cappuccina. Per quest'ultima cf. Ia lettera di Bernardino d'Asti, recentemente scoperta ed edita in I Frati Cappuccini. Documenti e testimonianze del primo secolo, vol. III/1, 44-46; e le riflessioni di Mattia da Salò, Historia Capuccina. Pars prima (MHOMC, V), Romae 1946, 365.
Nota 51 Cost. 4, 4; 12, 2-4; 60, 5-6; 100, 3;1 CPO, nn. 5b, 6, 9b, 48b, 60; IV CPO, n. 43-45. - Un esame di coscienza su questo aspetto e stato fatto dai cappuccini italiani nelle loro risposte al documento preparatorio «Proposta di lavoro». Cf. Sfide e controsfide, 61, 109, 157-167.
Nota 52 Cf. I CPO, nn.12d, 36-38; 111 CPO, n. 40, dove parla del servizio dei poveri come una delle scelte pastorali. Vedi anche nota 5 del I CPO e 145 del IV CPO.
Nota 53 I CPO, n. 35, 53. - Cf. le riflessioni opportune del Papa sulla vita fraterna e scelta dei poveri, nel discorso ai superiori provinciali italiani (1.3.1984): Anal. O.F.M Cap. 100 (1984) 57-59, inoltre F. Iglesias, Profetismo e Francesco. Note per una identificazione di alcuni tratti della nostra «originalità» apostolica, in Italia Franc. 62 (1987) 339-396; L. Iriarte, Presenza penitenziale e profetica del frate minore, in id., Temi di vita francescana, Roma 1987, 132189.
Nota 54 Cf. anche I CPO, n. 40, 45 e 63; IV CPO, n. 33-35.
Nota 55 I CPO, n. 21 g, 56; 111 CPO, n. 41. - In particolare cf. Viktrizius Veith, ll provincialismo nell'Ordine, in Italia Franc. 62 (1987) 436-446.
Nota 56 Cf. sopra, nota 36
Nota 57 Sopra, note 51-53.
Nota 58 Cost. 9, 3-4;1 CPO, n. 48 c, 52;111 CPO, n. 17-18.
Nota 59 Cost. 95, 1-9; 152, 2; 111 CPO, n. 40, dove accenna alla fraternità secolare francescana come scelta pastorale. - Jaime Zudaire, Con Francesco alla sequela di Cristo. Introduzione alla spiritualità e all'organizzazione dell'Ordine Francescano Secolare, 2. ediz., Roma 1991.
Nota 60 Cf. sopra, nota 24, e più avanti, nella V parte del documento, specie nota 105.
Nota 61 Il tema della povertà attraversa tutti gli ultimi documenti dell'Ordine. Cf. Cost. 59-74;1 CPO, nn. 46-61;11 CPO, n. 14;111 CPO, nn. 9, 40, 43; IV CPO, n. 43-45.
Nota 62 Vedi sopra, nota 41. - L'analisi della situazione sociale attuale si può trovare in molti documenti del Concilio Vaticano II come pure nelle encicliche Laborem exercens (14.9.1981) e Sollicitudo rei socialis (30.12.i987), e nell'esortazione apostolica Christifideles laici (30.12.1988), come pure in molti documenti della C.E.I.
Nota 63 Cf. Laici per una nuova evangelizzazione. Studi sull'esortazione apostolica «Christifideles laici» di Giovanni Paolo II, a cura di M. Toso, Leumann (Torino) 1990, Mariano D'Alatri, Francesco d'Assisi e i laici, in Ricerche storiche 13 (1983) 613-633; Augustina Marchetti Dori, Francesco e la donna, in Lettura delle Fonti francescane. Temi di vita francescana: La fraternità, Roma 1983, 213-220; Maria Mandelli, Donne, in Dizionario Francescano, 433-452, Paolazzi Carlo, Donne e dimensione femminile negli «Scritti» di san Francesco, in Studi Franc. 88 (1991) 393-415; P. Giglioni, Ministeri e servizi per la missione. La vocazione di ciascuno per il bene di tutti, Bologna 1990; vedi anche più avanti, nota 80.
Nota 64 Cf. Sfide e controsfide cit., 156-173.
Nota 65 Cf. Ia lettera del ministro generale a tutto l'Ordine: n nostro profetismo: vivere la nostra vocazione(7.10.1986), scritta alla fine del V CPO, in Anal. O.F.M. Cap. 102 (1986) 186-192, e anche in Lettere ai suoi frati cit., 193-202.
Nota 66 È un aspetto ribadito continuamente dall'insegnamento della Chiesa. Per l'America Latina cf. Paolo Evaristo card. Ams, Puebla: i diritti umani e lo spirito francescano, in «Costruisci la mia Chiesa». Ispirazioni francescane per e dal Terzo Mondo, Bologna 1983, 133-147.
Nota 67 Cost. 14, 4; 44, 4; 45, 8; 97, 4; 98, 3. - Cf. Cornelio Del Zotto, Francesco d'Assisi: Cristo pienezza dell'uomo, in n Fuoco 31 (1983) 26-42; E. Vigano, Mistero e storia. Dono e profezia del Concilio, Torino 1986, 201-210.
Nota 68 Cost. 59, 4-S; I CPO, n. 46; II CPO, n. 16; IV CPO, nn. 26-27, 40, 44, 78. - Cf. Michel Mollat, La povertà di Francesco: opzione cristiana e sociale, in Concilium 17 (1981), fasc. 9 43-SS; Anton Rotzetter, La scelta di san Francesco per i poveri, in Riv. Vita Spirit. 36 (1982) 6279; Norbert Nguyen-Van-Khanh, Le Christ dans la pensee de saint François d'Assise d'apres ses ecrits, Paris 1989; ed. ital., Milano 1984.
Nota 69 Cost. 59, 6-8; 61, 1-2; 67, 1-5.
Nota 70 Cost. 60, 4. - Cf. G. Santarelli, ll profetismo nella tradizione dell'Ordine, in Italia Franc. 62 (1987) 305-326.
Nota 71 I CPO, nn. 48 e 53. - Vedi anche Sfide e controsfide cit., 261-269 (= Servizio dei poveri), e sopra, nota 48.
Nota 72 Cf. nota 52. - Per quanto riguarda eventuali esperienze coi poveri durante il periodo di formazione, si tenga presente ciò che è stato precisato nel documento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica: Direttive sulla formazione negli istituti religiosi (2.2.1990), nn. 27-28.
Nota 73 È il criterio costantemente suggerito dalle nuove Costituzioni e dai documenti dei precedenti Consigli Plenari, pur tenendo conto anche della precisazione del III CPO, n. 13 dove si parla dell'opzione preferenziale per i poveri. Cf. Fabricio Ciampicali, L'opzione dei poveri nella tradizione francescana, in Frate Franc. 55 (1988) n. 3, 45-53; A. Lorscheider, Le attese dei poveri e la speranza francescana, in La speranza, 2 voll., Roma 1984, 339-356, L. Boff, Francesco d'Assisi. un'alternativa umana e cristiana. Una lettura a partire dai poveri, Assisi 1982.
Nota 74 Oltre l'esortazione apostolica di Paolo VI, Evangelii nuntiandi (L'impegno di annunciare il Vangelo) del 1975, si veda ora la lett. enciclica di Giovanni Paolo II, Redemptoris missio, circa la permanente validità del mandato missionario (7.12.1990); inoltre, per san Francesco, cf. Orencio Llamazares, La vita apostolica francescana nella prospettiva di san Francesco, in Italia Franc. 62 (1987) 397-403.
Nota 75 Si veda il sussidio dell'Ufficio di Ricerca e Riflessione: Secolarità e nuova religiosità: per una lettura francescana, Roma 1991, P. Fernando Bastos de Avila, Le chiese cristiane storiche di fronte alla grande varietà di espressioni religiose del mondo di oggi, in Atti del II convegno degli studiosi dell'OFMCap. Roma, 6-15 sett. 1990), Roma 1991, 174-198.
Nota 76 È una situazione che varia pero nelle diverse circoscrizioni e aree culturali, come e apparso dalle relazioni delle singole Conferenze dell'Ordine.
Nota 77 Cf. IV CPO, nn. 18-20; Sfide e controsfide, 280-285 (= Ministero parrocchiale). Luca Brandolini, Fraternità religiosa e pastorale parrocchiale con riferimento alle Costituzioni dei cappuccini, Roma, CispCap. 1981.
Nota 78 Sfide e controsfide, 275-277.
Nota 79 Circa il processo d'identificazione con l'Ordine e il ruolo del fratello laico, temi trattati nel capitolo generale del 1988 cf. Anal.O.F.M.Cap. 104 (1988) 407-436; sull'apostolato tradizionale che non deve essere sottovalutato e immiserito e messo fuori moda cf. Sfide e controsfide, 271-274.
Nota 80 Sulla drammatica condizione femminile nel mondo cf. il primo rapporto dell'O.N.U.: World's Women 1970-199O.
Nota 81 Tuttavia la pietà, religiosità e devozione popolare sono importanti e devono essere valorizzate, purificate, rievangelizzate, come dice Giovanni Paolo II nell'encicl. Catechesi tradendae, n. 54; cf. anche III CPO, n. 40; G. Motta, Religiosità popolare, in Nuovo Dizionario di spiritualità, Roma 1979, 1316-1331.
Nota 82 Cf. Massimo Introvigne, La sfida delle sette, in Vita religiosa e nuova religiosità cit., 123 135; Subrack Josef, La nuova religiosità, una sfida per i cristiani, Brescia 1988.
Nota 83 Cf. III CPO, nn. 25-29, - vedi anche la dichiarazione della conferenza episcopale d'Asia del febbraio 1991 sul dialogo interreligioso: Se la Chiesa e comunità di dialogo, in Semmana n. 23 (16 genn. 1991) 7; Antonio M. Gentili, Religiosità orientale, in Vita religiosa e nuova religiosità, 136-145.
Nota 84 Si pongono al vaglio del discernimento nella grazia della Chiesa di oggi, per ricuperarne, ritradurne e completarne la forza di radicalità evangelica che contengono con l'apporto dei nuovi valori di coscienza personale e sociale e di comunione ecclesiale.
Nota 85 Cf. Sfide e controsfide, 287-294.
Nota 86 Questa «nuova fisionomia dell'Ordine,,, se e determinata e causata dalla potenza dello Spirito, non potrà che essere un arricchimento, mai un tradimento della genuina tradizione dell'Ordine» Cf. P. Rywalski Notre Ordre change de visage, in Fidelis 72 (1985) 131-137 C. Cargnoni, Rinnovamento dell'Ordine cappuccino. Tensioni, prospettive, confronti di attualità, in Italia Franc. 55 (1980) 419-436; id., Rinnovamento della vita cappuccina tra ambiguità spiritualistiche, tradizione e profezia, ibid. 61 (1986) 41-68 si veda, in particolare, ciò che Paolo VI e Giovanni Paolo II hanno espresso all'Ordine nei loro discorsi. Cf. Cari Cappuccini,. Discorsi di Paolo Vl ai Cappuccini, Perugia 1985; Giovanni Paolo II, Con Francesco nella Chiesa, Città del Vaticano 1983; F. Iglesias, Approccio alle fonti: invito e proposte dei Sommi Pontefici, Roma 1989.
Nota 87 Si rilegga in questo senso la relazione di Pasquale Rywalski tenuta a La Verna il 23 sett. 1976 durante il 1° incontro dei 4 ministri generali delle Famiglie francescane e rispettivi definitori: L 'apostolato francescano oggi, in P. Rywalski, Lettere ai suoi frati 1970-1982, Roma 1982, 434- 448; assai significative anche le precedenti lettere sull'apostolato. ibid., 202-209, 224-231,234-241.
Nota 88 Cost. 145, 1-7; 147, 1-6.
Nota 89 Cf. Ilarino da Milano, La «Chiesa dei poveri» e il francescanesimo, in Sfide e controsfide, 385-404, vedi anche nota 73.
Nota 90 Cost. 8, 4; 164, 1; 181, 2-3; I CPO, n. 7, 41; III CPO, n. 10, 15; IV CPO, nn. 36, 42. - Si legga ciò che dice l'attuale Papa sul carisma magisteriale della Chiesa e sulla fedeltà al Magistero, indispensabile per leggere rettamente i segni dei tempi: Anal. O.F.M. Cap. 102 (1986) 257-262, 265-269, Joseph Ratzinger, Unità e pluralismo nella Chiesa dal Concilio al post-Concilio, in Orient. Past. 33 (1985) 125-144, R. Paciocco, La proposta cristiana di Francesco d'Assisi e la Chiesa, in Riv. Storia della Chiesa in Italia 40 (1986) 134-140.
Nota 91 Cf. Cost. 6, 1-4; 164-167. Optatus van Asseldonk, Fisionomia della fraternità francescana in Italia Franc. 57 (1982) 631-640; L. Iriarte, I consigli evangelici nelle «Fonti Cappuccine», Roma, CISPCap. 1989.
Nota 92 Cost. 146, 1-5; I CPO, n. 48, 58; III CPO, n. 34, 39; utile anche la sintesi: Il rinnovamento della pastorale. Guida alla lettura della pastorale CEI 1970-1985, Bologna 1985.
Nota 93 È una sintesi delle varie indicazioni delle Costituzioni e Consigli Plenari. Cf. Cost. 15, 1; 146, 5; 147, 6; 154, 2; I CPO, n. 34, 48; III CPO, n. 36; IV CPO, n. 50.
Nota 94 Cf. Movimenti ecclesiali contemporanei, a cura di A. Favale, Roma 1982; L. Lehmann, I recenti movimenti ecclesiali ci interpellano, in Italia Franc. 64 (1989) 367-388; Theo Jansen, Il carisma francescano-cappuccino e i movimenti ecclesiali oggi, ibid. 66 (1991) 219-232; Bruno Secondin, I nuovi protagonisti. Movimenti, associazioni, gruppi nella Chiesa, Cinisello Balsamo (Milano) 1991.
Nota 95 I poveri col loro «grido» (cf. più avanti, n. 93) sono l'ansia, la tensione, la nostalgia, il pungolo della Chiesa e dell'Ordine. Cf. Cost. 4, 4; 12, 2-4; 14, 4; 59, 8; 60, 5-6; 100, 3, 145, 4; 149, 2, I CPO, nn. 4, 6, 9, 13; III CPO, nn. 6, 9, 13, 23, 40; IV CPO, nn. 18, 22, 36; e sopra, nota 57.
Nota 96 Cf. sopra, note 56 e 35-37.
Nota 97 Cf. La lett. apost. di Giovanni Paolo II Evangelii itinera (29.6.1990), in Anal. O.F.M. Cap. 106 (1990) 228-243; encicl. Redemptoris Missio (7.12.1990); inoltre il documento vaticano. Dialogo e annuncio. Riflessioni e orientamenti sul dialogo interreligioso e l'annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, sul quale cf. E. Franchini, Le religioni, il dialogo e lo Spirito, in Settimana, n. 25 (30 giugno 1991) 3; Evangelizzazione e comunità: perché il Concilio viva nelle Chiese locali, Roma 1978, E. Bromuri, L'Ecumenismo. Chiesa in cammino verso la piena comunione, Milano 1991, Marcella Farina, n cammino di una Chiesa: storia e prospettive, in Riv. Scienze dell'educazione 23 (1985) 400-408, Pietro Schiavone, Segni di una comunità riconciliata, in Presbyteri 19 (1985) 734-749.
Nota 98 Cost. 82, 3; 90, 1-3; 153, 1-6; II CPO, n. 28; III CPO, n. 47; IV CPO, n. 45. - Cf. Sfide e controsfide, 18, 22, 137, 174-179, e specie 303-305; R. Mancini, Comunicazione come ecumene. n significato antropologico e teologico dell'etica comunicativa, Brescia 1991.
Nota 99 Cf. ibid., 275-277; e sopra, nota 59; vedi anche l'edizione recente della regola e delle Costituzioni generali dell'OFS, a cura della Presidenza del Consiglio Internazionale dell'OFS, Roma 1991; e per la GIFRA: ll nostro volto. Statuto della Gioventù francescana d 'Italia. Forma di vita e norme organizzative, a cura della Segreteria Nazionale Interobbedienziale dell'OFS; inoltre G. Lazzari, Nel mondo con Francesco d'Assisi. Ricerche e riflessioni per una lettura fraterna della Regola dell'Ordine Francescano Secolare, Roma 1988, Manuela Mattioli, L'O.F.S. esperienza concreta di pacificazione, Roma 1986; L'assistenza spirituale all'OFS. Atti I corso di Aggiornamento per Assistenti Spirituali OFS e GIFRA delle province cappuccine di Sicilia, Gibilmanna 1991.
Nota 100 Cf. Ia sempre stimolante lettera pastorale dell'arciv. di Milano, card. Carlo M. Martini, In principio la Parola (8.9.1981); e vari elementi concreti nel convegno del 27-29 sett. 1983 a Milano, dei Frati cappuccini sulla: Metodologia dell'annuncio, Milano 1984; inoltre T. Giustiniani - F. Torielli, Nuova evangelizzazione, che cosa, come, Torino 1991; Nuova evangelizzazione. La discussione - le proposte, a cura di E. Franchini - O. Cattani, Bologna 1990.
Nota 101 Cost. 4, 4;150, 1-3; 86,1-6; - Circa la pastorale della sofferenza vedi la lettera apost. di Giovanni Paolo II, Salvifici doloris (11.2.1984), e la lettera circolare del ministro generale Flavio R. Carraro per gli ammalati (28.2.1990), in Anal. O.F.M. Cap. 106 (1990) 84-90; inoltre cf. Sfide e controsfide, 277-279, e specie 405-420 (con bibliog.).
Nota 102 Cost. 40, 4; 147, 3; 153, 5. - Sul problema dell'informazione e sulle edizioni all'interno dell'Ordine cf. Iettera del ministro generale, in Anal. O.F.M. Cap. 99 (1983) 95-100; 100 (1984) 11- 15; e sopra, nota 30. - Per l'apostolato delle famiglie e dei giovani cf. Direzione spirituale e cristiani comuni. Supplemento al n. 1 del 13 genn. 1991 di Semmana, Bologna 1991, Giulio Oggioni, Catechesi sul matrimonio e sulla famiglia, Casale Monferrato 1986.
Nota 103 Cf. Nello spirito di Assisi. Lettera dei ministri generali delle Famiglie francescane, Bologna 1987; sulla pace e non-violenza vedi soprattutto l'enciclica Centesimus annus, sulla quale cf. Giampietro Brunet, «Ventesimus annus», al centro l'uomo, in Settimana n. 18 (12 maggio 1991)1, 16; vedi anche le seguenti note.
Nota 104 Cf. Cornelio Del Zotto, Il dialogo universale di Francesco d'Assisi, pratica di pacificazione, in Anton. 65 (1990) 495-532, G. Lauriola, Francesco d'Assisi e la pace, Noci (Bari) 1986; G. Salvadori, San Francesco d'Assisi e la pace sociale, Roma 1982; T. Matura, La pace negli scritti di Francesco, in Vita Min. 59 (1988) 327-338; La pace, speranza dell'uomo, dono di Cristo. Atti del terzo Simposio sulla Valle francescana di Rieti (Rieti - Poggio Bustone 18-20 apr. 1986), a cura di U. Battaglia, Vicenza 1986;
Nota 105 Cf. Stanislao da Campagnola, L'amore della natura in Francesco d'Assisi - Love of nature in St. Francis of Assisi, in Rivista di biologia 75 (1982) 373-384, Candela Silvestro S. Francesco patrono dei cultori dell'ecologia. Documentazione testuale e carattere evangelico del Cantico delle creature, Napoli 1981.
Nota 106 Cf. Seul: Giustizia, pace e salvaguardia del creato, a cura di A. Filippi, Bologna 1990; Giuseppe Mastai, Un problema morale nuovo: I'ecologia, in Credere oggi 6/3 (1986) 88-99 (con bibliog.).
Nota 107 Cf. ad es. L'impegno dei francescani in Europa per la giustizia, la pace e la salvaguardia della creazione, in Vita Min. 60 (1989) 343-351; infine sulle prospettive del mondo moderno cf. Adelhelm Bunter, Il mondo che si prospetta alle soglie del 2000, in Italia Franc. 62 (1987) 447 457.
Nota 108 Cf. Lettera programmatica dei 4 ministri generali, Transundum est ad opera (26.2.1989), in Anal. O.F.M. Cap. 105 (1989) 51-64; come pure la lettera del ministro generale Flavio R. Carraro, Lettera programmatica «...passare ai fatti» (2.2.1989), Roma 1989; esse sono una risonanza al discorso del Papa, Imitate maggiormente san Francesco d'Assisi traducendo in fatti la sua scelta di vita (12.6.1988), in Anal. O.F.M. Cap. 104 (1988)163s.
Nota 109 Cf. Gianmaria Polidoro - Davide Marzaroli, Pace con il creato. Discorso cristiano sull'ecologia, S. Maria degli Angeli - Assisi 19822.
Nota 110 Cf. Attese dei cappuccini italiani dal V CPO, in Sfide e controsfide, 315-341.
Nota 111 Cf. Merino Jose Antonio, Umanesimo francescano ed ecologia, in Vita Min. 62 (1991) 323-332, 449-462, 511-525; vedi anche la nota pastorale della Commissione ecclesiale «Giustizia e Pace», Educare alla legalità, Bologna 1991.
Nota 112 Cf. Manuel C. das Neves, Francisco de Assis, profeta da paz, in Itiner. 33 (1987) 26- 204, e a parte, Lisboa 1987.
Nota 113 Cf. Cornelio Del Zotto, «Il Signore ti dia pace»: la catechesi pasquale in san Francesco d Assisi, in Vita Min. 57 (1986) 257-268;
Nota 114 Cf. note 24 e 60. - Vedi inoltre: Pietro Luzi, Francesco d'Assisi. Guida spirituale di comportamento con l'ambiente, Torino 1989; F. Cardini, Francesco e il fuoco. Dalla «creatura ignis» al sersafino fiammeggiante, in Studi Franc. 80 (1983) 297-308; A. Marini, Sorores a laudae. Francesco, il creato, gli animali, S. Maria degli Angeli - Assisi 1989; Pasquale Magro, San Francesco e la coscienza ecologica, in San Francesco Patrono d'ltalia 67 (1987) n. 11, 25-40, F. Botazzi, Gli animali, creature di Dio. La lezione di san Francesco, in Riv. Teol. Morale (Bologna) 21 (1989) n. 82, 15-20.
Nota 115 Cost. 3, 1; 11, 5; 12, 5; 46, 7; 98, 4; 99, 1-3; 131, 4; 167, 5; 169, 3; I CPO, n. 9, 17; 111 CPO, nn. 12, 13, 15; IV CPO, nn. 6, 8, 44, 52. - Cf. L. Iriarte, Riconciliazione e perdono, via francescana della pace, in Italia Franc. 60 (1985) 427-438.
Nota 116 Cf. il documento della Commissione ecclesiale della CEI «Giustizia e Pace», Uomini di culture diverse: dal conflitto alla solidarietà (Documenti, ns., n. 39), Bologna 1990; Sfide e controsfide, 306-314 (= Impegno per la giustizia e la pace - Evangelizzare l'ecologia).
Nota 117 Per la storia del nostro Ordine cf. Mariano D'Alatri, Antesignani dell'Europa unita, Roma 1979.
Nota 118 vedi sopra, nota 22.
Nota 119 sopra, note 65, 72-73, 95.
Nota 120 Cf. O. Schmucki, Iniziazione alla vita francescana alla luce della Regola ed altre fonti primitive, in Italia Franc. 60 (1985) 27-50, 397-426 (con bibliog. sulla pedagogia francescana); F. Iglesias, Alcune istanze formative nei documenti e nelle testimonianze del primo secolo cappuccino, Roma 1990, ll formatore dei religiosi nella Chiesa, oggi, Roma 1984.
Nota 121 Cf. Anton Rotzetter, Per una strategia di pace secondo Francesco d'Assisi. Inquadramento teologico ed attualizzazione, Roma, CispCap. 1984; E. Testa, La strategia della non-violenza di frate Francesco, in Forma Sororum 22 (1985) 178-205.
Nota 122 Cost. 99, 1-3. - Cf. Ia lettera del ministro generale Flavio R. Carraro all'inizio del sessennio 1982-1988: Programma del sessennio (1.11.1982), in Anal. O.F.M. Cap. 98 (1982) 329- 334, e in Lettere ai suoi Frati cit., 15-23.
Nota 123 È una revisione particolare della nostra vita fraterna, già toccata sotto altri profili ai nn. 25 e 38. Per quanto riguarda una certa «declericalizzazione» dell'Ordine cf. le riflessioni dei cappuccini italiani, in Sfide e controsfide, 222-225 (= La grazia e il dono dei fratelli, 363 384 (= Eutimio Rainoldi, Francesco d 'Assisi oltre il sacerdozio ministeriale).
Nota 124 Sulle iniziative delle altre famiglie francescane cf. G. Iammarone, La testimonianza francescana nel mondo contemporaneo, Padova 1988.
Nota 125 Vedi alcune esemplificazioni della spiritualità della nostra vocazione francescana nel contesto ecclesiale di oggi suggerite da Optatus van Asseldonk, una spiritualità per domani: Maria, Francesco e Chiara, Roma 1989, 461-490.
![[Barra link interni]](../comimage//barratrz.gif)
|
Pagine realizzate e gestite per i Frati minori cappuccini da fra Mario
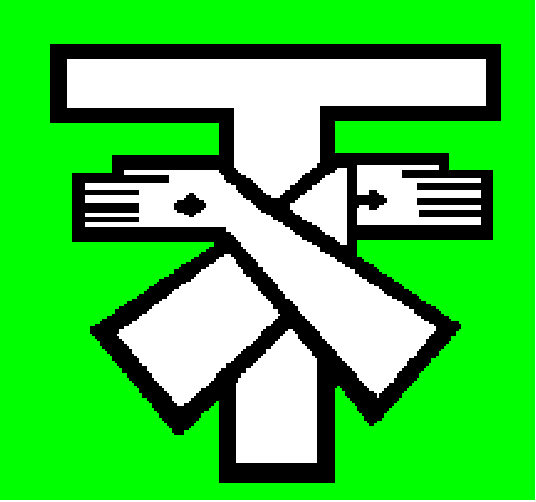
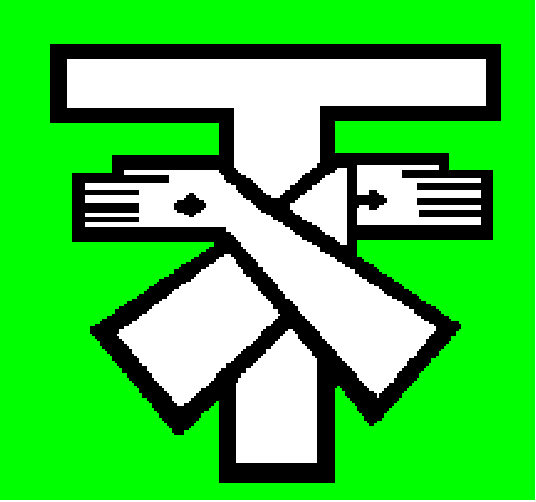
![[Barra link interni]](../comimage//barratrz.gif)